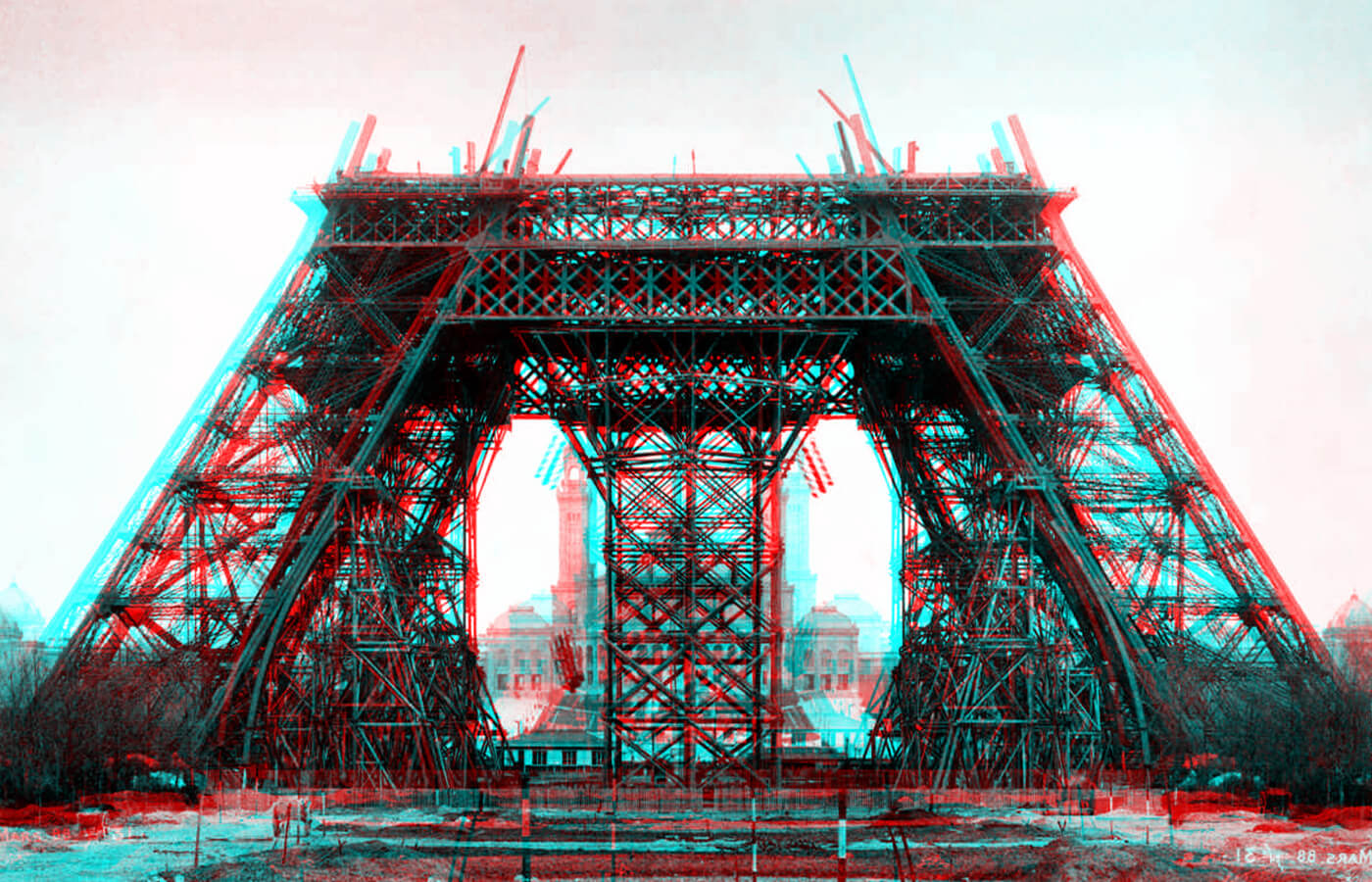Città e Percezione – “L’immagine della città” di Kevin Lynch: recensione
La città.
Proiezione di futuri impossibili. Utopie e distopie.
Eterotopie. Magari. (Magari il manicomio?)
Scenari post-apocalittici e desertici. Il nostro giudizio universale si avvicina e i cavalieri di San Giovanni iniziano a tagliare teste sul loro cammino.
Il futurismo è morto. E adesso ci tocca vivere il futuro. Certamente non l’avevamo immaginato così.
I nostri sogni sono cambiati al cambiare delle nostre ambizioni. Prima ci piaceva l’idea che ogni cosa girasse intorno alle macchine.
L’industria era l’unico vero credo.
Poi la gente aveva iniziato ad ammalarsi, le città ad affollarsi. Fogne a cielo aperto, scorie e fuliggine per tutti. E in un baleno il mito della macchina non esisteva più.
Era necessario separare in zone specializzate ed esclusive. Tanto c’era l’automobile a risolvere il problema delle distanze.
Mitologie urbane
A sostituirlo arrivò il mito del parco.
Una vera bestia mitologica. Che non risolveva nessuno dei problemi che avevamo.
I poveri continuavano ad essere poveri che abitavano in case minuscole. Celle di un alveare in giganteschi complessi abitativi. Ma meravigliosamente immersi in un mare di verde e solitudine.
Ma in più adesso c’era la questione dello zoning. Gran bella novità la segregazione. Una malattia da cui raramente un quartiere guarisce.
E come un macigno la verità era caduta sopra le nostre teste.
L’uomo è un virus. Come diceva il saggio agente Smith.
E, in un secondo, prima che la Terra si trasformasse irrimediabilmente in Zion, studiosi di ogni tipo cercavano di farci riemergere dal mare di merda in cui ci eravamo inabissati. Visto che ogni azione fino a quel momento era stata causa di altri guai.
Non abbiamo ancora imparato che interesse e benessere non coincidono. Quasi mai.
Anzi, fino ad oggi abbiamo continuato a cercare di correggere il tiro nella speranza di diminuire il danno, ma continuando a perseguire i nostri miseri obiettivi.
A questo punto c’è il rischio di sembrare uno di quegli stronzi hippie strafatti senza uno scopo preciso nella vita. Ma purtroppo questa è l’amara verità: l’essere umano raramente sa scegliere bene tra il guadagno a breve termine e il benessere a lungo termine.
Gli studiosi sopracitati si risvegliavano lentamente dal loro torpore siderale. Un allarme risuonava nelle loro teste:
I vari Le Corbusier e Hilbersimer, nonostante i nobili propositi, ci avevano fatto sprofondare ancora di più nella merda.
Merda.
E adesso come si fa?
La lotta contro la dispersione funzionalista: la rivolta dei giovani architetti
Tra gli anni cinquanta e sessanta, quando Corbu e compagnia cantante erano gli intoccabili, qualcuno aveva iniziato ad Osservare.
E semplicemente aveva smesso di sparare teorie sulla progettazione. Il mondo dell’architetto salva-uomo, così come lo conoscevamo, era finito.
L’onta era stata insopportabile.
In effetti non siamo ancora riusciti a superare il trauma del tutto. Qualcuno continua ancora a negare la realtà e a proporre di adibire una zona morta a parco morto.
Questi giovanotti avevano la presunzione di cambiare il mondo.
Nella saga interstellare nota come CIAM, alcune teste calde incominciavano a progettare un colpo di stato.
La Ville Radieuse non aveva niente di radieuse.
Avevano capito che era inutile trattare la questione come un esercizio di stile o un calcolo matematico. Usare degli standard non era sufficiente. Per comprendere i fenomeni urbani bisognava piuttosto immergersi ed entrare nel tessuto urbano, farne parte, sentirsi parte di questo.
Si scopriva, con orrore e stupore, che ogni cosa apparteneva ad un sistema più grande. Sempre più articolato e sempre più ingestibile. Era necessario dare dei significati per poter agire.
Insomma, progettare radendo al suolo il centro storico era, in definitiva, una minchiata solenne.
Sociologia urbana e percezione
A proposito di osservazione, i sociologi salirono alla ribalta. Si unirono ad architetti, urbanisti e filosofi e iniziarono un lunghissimo e intricatissimo dibattito.
La nascente sociologia urbana iniziava a mettere pulci nelle orecchie e a dare manforte agli architetti ribelli. Qualcuno iniziava a sentire fortemente il legame con il passato e non nel senso stilistico del termine. Niente storicismi, per intenderci.
La città doveva smettere di accumulare frammenti sconnessi e ricominciare ad essere un totale vivo ed eterogeneo.
Chi di noi può affermare con certezza di conoscere palmo a palmo la propria città?
Kevin Lynch aveva intenzione di rispondere a questa domanda. E aveva scritto “L’immagine della città”.
Testo pionieristico e fondamentale di cui parla questa non-recensione (o breve riassunto).
Lynch era tra quelli che aveva deciso di osservare. Aveva scelto 3 città completamente differenti fra loro, nella speranza di capire cosa diavolo non funzionasse, per poi tradurlo in progetto.
Anzi in processo. A stadi e in divenire continuo.
Certamente aveva capito che pensare ogni nuovo quartiere e, più approssimativamente, ogni città come fosse un manufatto unico, slegato e senza radici era quanto di più folle si potesse fare per rendere lo spazio urbano migliore.
Non eravamo più nel rinascimento, quando l’urbanistica era solo una scienza teorica. Per lo più finalizzata a scopi militari e difensivi. Si disegnavano città spinose, irrealizzabili ma di grande effetto scenico.
Utopie.
E nemmeno nel Settecento antropocentrico, quando l’architetto aveva smesso di costruire e aveva iniziato a disegnare ossessivamente città immaginarie senza realizzarne quasi neanche una.
Profeti dell’urbanistica.
Erano in preda ad una specie di schizofrenia da progetto.
L’immagine della città secondo Lynch: una questione di esperienza
Lynch aveva deciso di partire dal basso. Dall’esperienza che ognuno di noi ha della città. Aveva preso un campione di persone da Boston, Jersey City e Los Angeles e aveva chiesto loro cosa si ricordassero della propria città.
Basando tutto sulla questione della percezione dello spazio. Un tema caldo.
Partendo da qui aveva incominciato a indagare. Era deciso a trovare una soluzione alla crisi spaziale e di sviluppo urbano.
Il ragionamento era logico e semplice: se ti ricordi dettagli, percorsi e riferimenti della tua città, se riesci ad orientarti senza vivere l’esperienza traumatica dello smarrimento, allora è probabile che la tua sia città ben costruita, seppure inconsapevolmente.
Naturalmente è escluso che questo fenomeno si verifichi in egual misura per tutta l’estensione urbana, specialmente se si tratta di metropoli.
Ma è altrettanto probabile che individuare dei fattori comuni che fanno di un quartiere o di una porzione di città un’area viva e godibile, può essere uno strumento attivo nella progettazione.
Lynch sosteneva che ogni elemento all’interno di una città avesse tre caratteristiche principali: identità, struttura e significato. Comprendendo che il significato potesse essere molto soggettivo e quindi inutile da un punto di vista analitico (almeno a questo stadio di ricerca), si era soffermato sui primi due termini.
Lo studio di Lynch era diviso in due fasi: intervista e sopralluogo.
Aveva introdotto il concetto di figurabilità (imageability): la capacità che la città ha di rimanere impressa nella testa della gente che la esplora quotidianamente o potenzialmente e di trasformarsi in una mappa mentale attraverso cui riuscire ad orientarsi.
Ad esempio: descrivimi il percorso che compi ogni giorno per andare a lavoro completo di tutti i dettagli che ricordi.
Le mappe mentali: 5 elementi per orientarsi
Mettendo insieme le esperienze e sovrapponendo le descrizioni dettagliate di tutti i partecipanti all’esperimento, aveva riscontrato che molte caratteristiche ricorrevano e molte altre venivano dimenticate, oppure confuse, oppure estese a zone in cui non erano più effettivamente presenti.
Aveva scoperto che esisteva una, per così dire, visione comune della città.
Una mappa mentale collettiva (o condivisa?).
Ogni elemento con cui si definisce una mappa collettiva è fondamentale per l’orientamento e, di conseguenza, determinante per far nascere il senso di appartenenza alla propria città. Con una serie di buone conseguenze.
Vivibilità, sicurezza, godibilità. Vivacità.
La gente immaginava di muoversi in uno spazio definito da 5 elementi:
– percorsi
– margini
– nodi
– quartieri
– riferimenti
Ognuno, attraverso questi elementi, era in grado di dare struttura alla propria mappa definendo intensità e grado di importanza per la propria esperienza. Il disegno che ne scaturiva doveva essere abbastanza definito da consentire l’orientamento, ma non troppo rigido da impedire agli esploratori di città di aggiungere nuove porzioni alla propria mappa.
Attraverso questo studio, Lynch era in grado di provare quanto fosse fondamentale il disegno urbano e quanto fosse necessario riferirsi all’esperienza percettiva per costruire uno spazio che sia stabile ma allo stesso tempo flessibile.
Lynch anticipava i tempi della liquidità moderna e tentava di mettere ordine nel caos totale della metropoli. Forse immaginava che sarebbe stato sempre peggio.